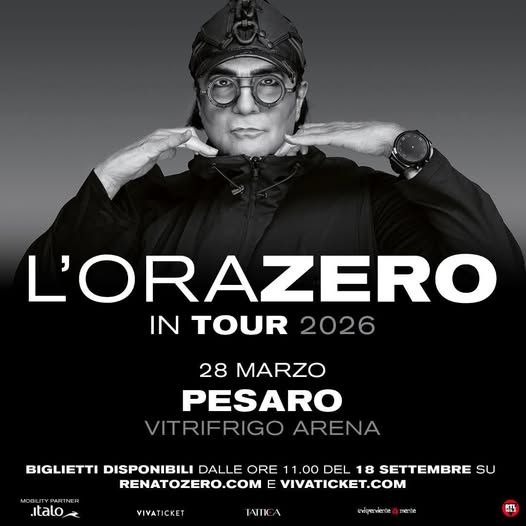Pubblicato il 6 Ottobre 2021
di Stefano Fabrizi
Si è svolta ad Ancona la prima Conferenza Nazionale su L’Arte e il Design organizzata dalla Poliarte diretta da Giorndano Pierlorenzi. Diversi i temi affrontati come il dotare il capolavoro d’arte di un microcip e valutare con un nuovo algoritmo il calcolo di rischio per la stessa opera d’arte, e non solo. Di questo ultimo punto ne abbiamo parlato con Genséric Cantournet e Angela Pietrantoni, rispettivamente presidente e Ceo della Kelony (https://kelony.com/). Dopo il video dell’intervista segue la relazione presentata alla conferenza.
Introduzione
Nel mondo dell’arte odierno viene spontanea la domanda: l’arte di domani sarà fatta da NFT, Blockchain e criptovalute ? Cosa sta veramente cambiando?
L’11 marzo scorso è stata battuta all’asta da Christie’s, per quasi 70 milioni di dollari, pagati in criptovaluta, l’opera Everydays — The First 5000 Days, l’NFT di un gigantesco Jpeg. Gli NFT (acronimo di Non-fungible token) sono una tecnologia che garantisce il concetto di non riproducibilità nel mondo digitale, nel quale invece vige il paradigma della riproduzione.
Più che una soluzione però gli NFT rappresentano un Rischio che potrebbe superare di gran lunga le potenzialità economico-finanziarie attese. Il Rischio è quello che gli NFT per quanto possano dimostrare la proprietà di un’opera digitale, non possono in nessun modo dimostrare la legittima della proprietà o della transazione a monte dell’appropriazione. Un Rischio del contrappasso quindi: quello di fare certificare una frode, un furto o un operazione di riciclaggio!
Noi del World Protection Forum™, supportati dagli strumenti di matematica avanzatissima di KELONY®, abbiamo immediatamente voluto dare un supporto operativo al progetto di Giuseppe Miceli sulla tutela delle opere d’arte e dei beni culturali.
Vediamo insieme il perché dell’uso della matematica applicato all’arte, di come sia funzionale all’autenticazione delle opere, infine di capire come deve essere calcolato il Rischio collegato a trattative illecite e quali possono essere gli strumenti di tutela del mercato dell’arte.
I. Scientificità dell’approccio: la Matematica e l’arte
In realtà arte e matematica sono da sempre profondamente collegate e nutrono una fruttuosa relazione storica.
Come non pensare ai sangaku, letteralmente le “tavolette del tempio”, ormai parte del Tesoro Nazionale giapponese: tavolette di legno dedicate ad un altare o a un tempio Shinto o Buddista, che rappresentano proprietà matematiche o risoluzioni di problemi matematici.
O ai frattali polimorfici di Joy Leys, o all’artista-matematico Patrice Jeener e alle sue incisioni matematiche le cui superfici minimizzano le proprie aree, esattamente come avviene in natura quando per un dato volume, la superficie che minimizza l’energia è una sfera. Motivo per il quale le bolle di anidride carbonica nell’acqua frizzante sono sferiche.
Pensiamo anche alle funzioni matematiche di Karl Weierstrass che hanno la proprietà di essere continue in ogni punto ma di non essere derivabili in nessuno, rappresentate da Patrice Jeener:
La matematica è presente ovunque nell’arte anche nella pittura classica, sia quando la simbologia matematica viene direttamente rappresentata come nella Malinconia di Albrecht Dürer, sia quando l’opera utilizza strumenti matematici quali la geometria, come ad esempio la prospettiva definita dal poliedrico artista Rinascimentale Leon Battista Alberti e abilmente sfruttate da un Piero della Francesca nella sua Resurrezione.
Il connubio tra matematica e arte, anche tramite la geometria prosegue nei secoli fino alle opere di Escher e Vasarely.
Oltre alla prospettiva classica, è molto interessante notare come elementi di geometria non euclidea siano stati scoperti quasi contemporaneamente da matematici e artisti, come ad esempio il triangolo di Roger Penrose, scoperto in ambito matematico nel 1950 ma che l’artista svedese Oscar Reutersvärd disegno già nel 1934.
E i vari esempi non si limitano all’arte grafica, bensì spaziano fino alla musica, con ad esempio il “glissando” di Shepard-Risser, equivalente musicale delle scale grafiche infinite di Penrose. Trattasi di un suono che consiste in una sovrapposizione di onde sinusoidali separate da ottave, che crea l’illusione uditiva di un tono che sembra continuamente salire o scendere all’infinito:
Questo continuo intreccio tra arte e matematica ci indica chiaramente che la via della terzietà indipendente sui temi di “autenticità” e “legittimità delle transazioni o della proprietà”, non possono in futuro che essere scientifici e matematici.
II. Inversione di paradigma tra proprietà e autenticità
Il tema non è solo quindi di rintracciare le informazioni di prorietà relative al copyright, come quando si integrano dati audio grazie alla tecnologia DRM (Digital Rights Management) per la musica, ma di poter autenticare che l’opera sia originale e che la provenienza o la destinazione siano legittime.
L’esigenza è fondamentale:
- Sia ai sensi del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, che recepisce la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- Sia relativamente al Rischio di contraffazione.
Tutti e due i rischi avendo come comune denominatore la tutela della reputazione dell’intero settore dell’arte.
Detto altrimenti, è importante distinguere il mezzo di autenticazione dal processo di controllo dell’origine o della destinazione. In questo gli NFT possono tutt’al più essere uno strumento, vettore di tali informazioni, ma dal momento che l’NFT può essere emesso da chiunque, non fornisce certezze sull’autenticazione, ma rende solo atto del primato di chi lo ha emesso. Ad esempio l’emissione dell’unico NFT lecito emesso sull’opera della Gioconda non è di Leonardo da Vinci, ovviamente. Il problema cardine è che niente al momento garantisce che l’autore dell’opera sia anche colui che ha emesso l’NFT.
Gli esempi al punto precedente, di quanto arte e matematica siano collegati danno un chiaro indizio che le opere d’arte, di qualsiasi tipo, posseggono un “DNA” di stampo matematico. È quindi scientificamente possibile garantire l’autenticità di un’opera d’arte tramite le sue caratteristiche matematiche, non palesemente evidenti o note. Esattamente come questo avviene per le misure antifalsificazione delle banconote (metodo “TOCCARE, GUARDARE, MUOVERE”).
Facciamo un esempio concreto. Come non poter rendere omaggio a Charlie Watts, il leggendario batterista e cofondatore dei Rolling Stones, da poco scomparso? Vediamo quindi quello che rende l’opera dei Rolling Stones unica e inimitabile.
Oltre la melodia, la scenografia, le parole o lo stile, esiste qualche cosa che caratterizza i Rolling Stones inequivocabilmente: quello che li distingue veramente è che è l’unico gruppo di rock al mondo nel quale il batterista, Charlie Watts per l’appunto, segue il chitarrista (Keith Richards). Questo crea un impercettibile ritardo della batteria sul resto del gruppo, marchio inconfutabile dello stesso.
Le riproduzioni digitali del brano rendono il fenomeno tanto più impercettibile che le tecniche di compressione audio, semplificano e distruggono alcune informazioni, alterando le onde armoniche. Solo tecniche di analisi quali l’algoritmo di matematica avanzata AlgoSev™, ideato da KELONY® riescono a rilevare tali peculiarità, definendo quindi scientificamente e oggettivamente un elemento di autenticità direttamente collegabile all’unicità umana (quelli del DNA) degli autori dell’opera. Meglio ancora quindi che la marchiatura molecolare.
KELONY® calcola quindi il valore di un’opera calcolando l’indice della quantità di Rischio di alterabilità dell’opera stessa ma anche della sua autenticità, secondo il metodo scientifico e matematico della nuova Scienza del Rischio.
III. Introduzione al calcolo del Rischio e strumenti di tutela
Il mercato dell’arte rappresenta circa 65 miliardi di euro all’anno, mentre il mercato nero dell’arte emerso è valutato fino a 8 miliardi di dollari all’anno, cioè il 12%.
Sinteticamente potremmo suddividere il mercato dell’arte in operazioni sane (S), a rischio (R), e già fraudolente per contraffazione o riciclaggio per esempio (F). I due parametri da tenere in considerazione sono il tasso a di penetrazione delle operazioni fraudolente, cioè la quantità di operazioni sane suscettibili di diventare a rischio, nonché il fattore moltiplicativo b di operazioni a rischio che diventano effettivamente fraudolente in un lasso di tempo Dt:
- aSRDt è la quantità di operazioni a rischio che si creano,
- bRDt è l’aumento della quantità di operazioni fraudolente,
- ((aS – b) x RDt) è la variazione del numero delle operazioni a rischio.
Questo modello di calcolo differenziale ci indica chiaramente che il Rischio aumenta proporzionalmente all’aumento delle operazioni a rischio, cioè se la seguente condizione si verifica:
aS – b > 0
La variabile essenziale è quindi il quoziente b/a: se il numero di operazioni sane è inferiore al quoziente, il Rischio non dilaga.
Paradossalmente quindi il numero di operazioni fraudolente non dipende dalle operazioni a rischio bensì dal numero di operazioni sane. Bisogna quindi concentrarsi sulla difesa del perimetro delle operazioni sane e non sul voler eradicare il numero di operazioni a rischio, ma solo mantenerle al di sotto del quoziente precedentemente calcolato.
Concretamente è fondamentale dare atto e attuare progetti quali quello ideato da Giuseppe Miceli che tutelano per l’appunto il perimetro delle opere che non possono che dare luogo a operazioni sane, sia perché garantiscono l’autenticità dell’opera, sia perché adempiono agli obblighi di antiriciclaggio.
Il principio primario di tutela è quello della tracciabilità e della non-ripudiabilità. Proprio per questo motivo la tecnologia della Blockchain, una sorta di grande libro mastro pubblico e inalterabile, è apparsa come una possibile soluzione.
Una soluzione digitale quindi che sembra anche andare di pari passo con una progressiva digitalizzazione del mercato dell’arte. Ricordiamo che le transazioni “online” dell’arte erano pari all’8% del mercato totale nel 2019 e che la pandemia ha accelerato questa tendenza.
È in questo contesto di evoluzione digitale del mercato dell’arte e di entusiasmo degli investitori per le criptovalute, che sono apparsi gli NFT basati su tecnologia Blockchain, non solo come possibile soluzione per tracciare le opere d’arte ma anche come una nuova nicchia del mercato dell’arte, cioè l’arte puramente digitale come con i cryptopunks e cryptokitties. L’NFT rivoluziona il mondo dell’arte in quanto un artista che crea un’opera digitale (video, disegno, musica, ecc.) può definirla come l’originale e proteggerla da qualsiasi duplicazione, non solo garantendone l’autenticità a un potenziale investitore, ma anche la tracciabilità in futuro dell’insieme delle transazioni.
E proprio perché l’NFT agisce come un certificato digitale di autenticità e proprietà, può essere comprato e venduto come un asset a sé stante, creando di fatto un ulteriore mercato derivato. Pensiamo ad esempio alla distruzione dell’opera fisica “Morons” dello street artist Bansky per aumentare esponenzialmente il valore del NFT associato a quest’opera, unico elemento virtuale rimasto a testimonianza dell’opera.
Gli NFT rappresentano a dir poco uno sconvolgimento del mercato tradizionalmente e principalmente regolato da 9 istituzioni: il Museum of Modern Art (MoMA), il Guggenheim Museum, le gallerie Larry Gagosian e Pace, la Tate Modern di Londra e il Centre Pompidou di Parigi, e le 3 case d’asta Christie’s, Sotheby’s e Phillips.
Per questo motivo alcuni attori del mondo dell’arte tentano di sviluppare piattaforme digitali, di impegnarsi nell’e-commerce e di attribuire certificati di autenticità e varie garanzie sulla firma dell’artista. Questo tentativo di riguadagnare un perimetro ormai incrinato pone due grandi criticità:
- In primo luogo un chiaro conflitto di interesse: non si può essere contemporaneamente attore all’origine della vendita e ente terzo imparziale e disinteressato nel garantire l’autenticità e la legalità della transazione.
- In secondo luogo non è di certo funzionale alla reputazione del mercato voler tendere alla “tuttologia”, al voler far credere di essere bravi in tutto. Il tempo necessario all’acquisizioni delle dovute competenze, abbinato alla scarsità del tempo stesso a disposizione necessita di fare delle scelte: non si può diventare contemporaneamente esperti nell’ambito dell’arte e del Rischio che l’opera non sia autentica o che la transazione non sia legittima o lecita.
Ricordiamo che il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, obbliga gli operatori del mercato dell’arte a:
- svolgere l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,
- adottare delle procedure operative volte a mitigare e gestire tali rischi,
- implementare dei corsi di formazione interni in materia di prevenzione e gestione di tali rischi,
- svolgere un’adeguata verifica della clientela, conservando la relativa documentazione per un periodo di 10 anni.
Il Rischio è chiaramente quello di non riuscire a adempiere nella sostanza a quanto richiesto dal quadro normativo, proprio perché è poco credibile che un soggetto del mercato dell’arte sia anche un bravo investigatore.
Altri rischi collegati all’uso degli NFT sono il fatto di relegare l’aspetto artistico dell’opera in secondo piano, dopo l’opportunità di investimento in criptovalute. Ricordiamo che un’opera realizzata tramite un elaborato dati è frutto di una intermediazione digitale che appiattisce qualsiasi elemento stilistico, che nel caso delle arti grafiche ad esempio non permette di valutare la “pennellata”. Senza contare il Rischio legato all’altissima volatilità del mercato delle criptovalute stesse e alla scarsa regolamentazione delle loro piattaforme di scambio.
In sintesi, il problema è molto semplicemente che chiunque può creare un NFT a partire da qualsiasi cosa: l’NFT non fa che garantire l’autenticità e la non-ripudiabilità di sé stesso, non dell’opera collegata. Tutt’al più garantisce la tracciabilità delle eventuali transazioni passate e il diritto di seguito.
In chiaro, non è importante l’NFT di per sé, ma chi lo emette. Ecco perché l’affiancamento da parte di KELONY®, in qualità di Independent Assurance Services Provider ai sensi della Directive proposal UE del 21 di aprile 2021, al mondo dell’arte rappresenta una via percorribile al fine di neutralizzare sia il Rischio di riciclaggio sia quello della contraffazione.
Conclusione
In tale contesto gli NFT appaiono meno come una rivoluzione che come un nuovo mezzo tecnologico di tracciamento messo al servizio dell’arte e della speculazione nel settore delle criptovalute.
Un mezzo utile all’arte, a due condizioni tassative:
- La prima: poter garantire l’autenticità dell’emissione e l’affidabilità delle parti, intesa come portatrici della minor quantità di Rischio possibile.
- La seconda: garantire una chiara separazione dei ruoli tra chi opera sul mercato e chi è responsabile dell’autenticità e della legalità della transazione, calcolata come la quantità di Rischio ad essa associata.
In conclusione è urgente e importante proteggere in priorità le opere d’arte con:
- Gli indici di Risk-Rating più alti,
- il minor numero di elementi scientifici-matematici di disambiguazione e di indiscutibile autenticità.
La protezione delle opere d’arte e dei Beni Culturali non è u solo n problema di arte e di mercato, bensì un problema di civilizzazione, perché è più civile chi maggiormente protegge.