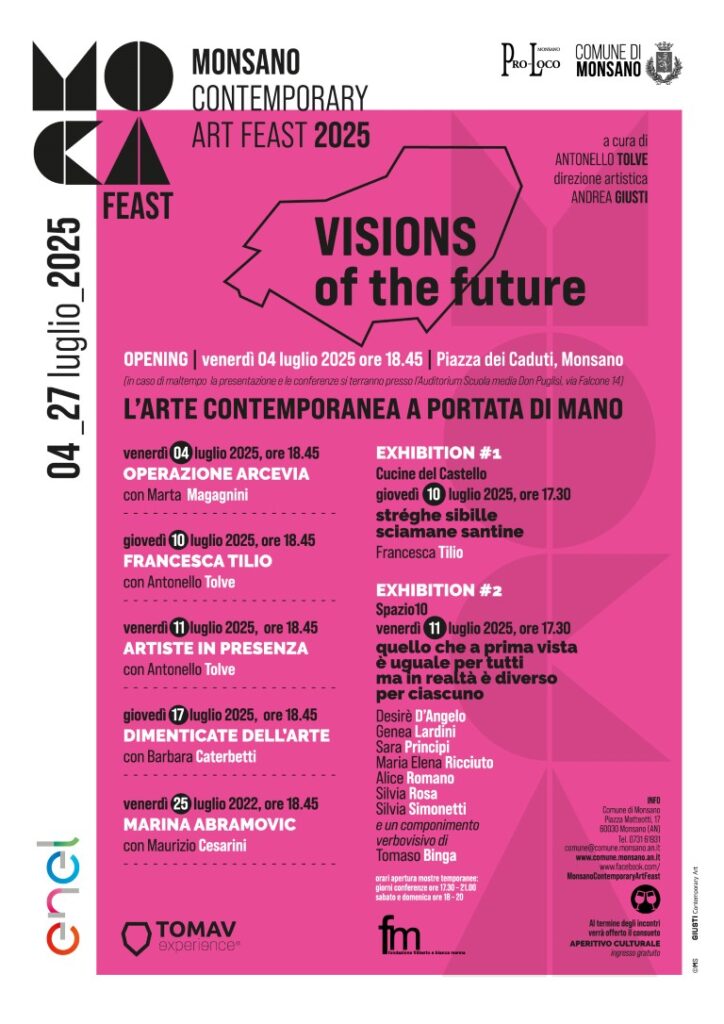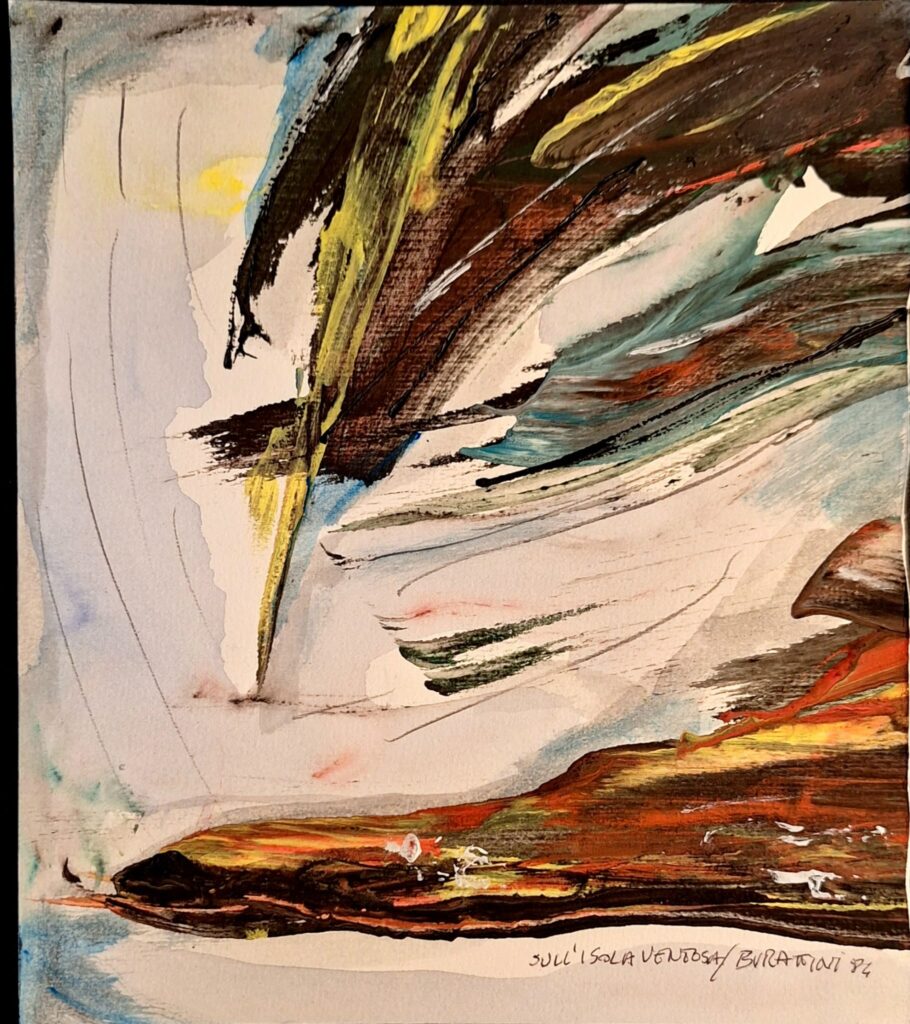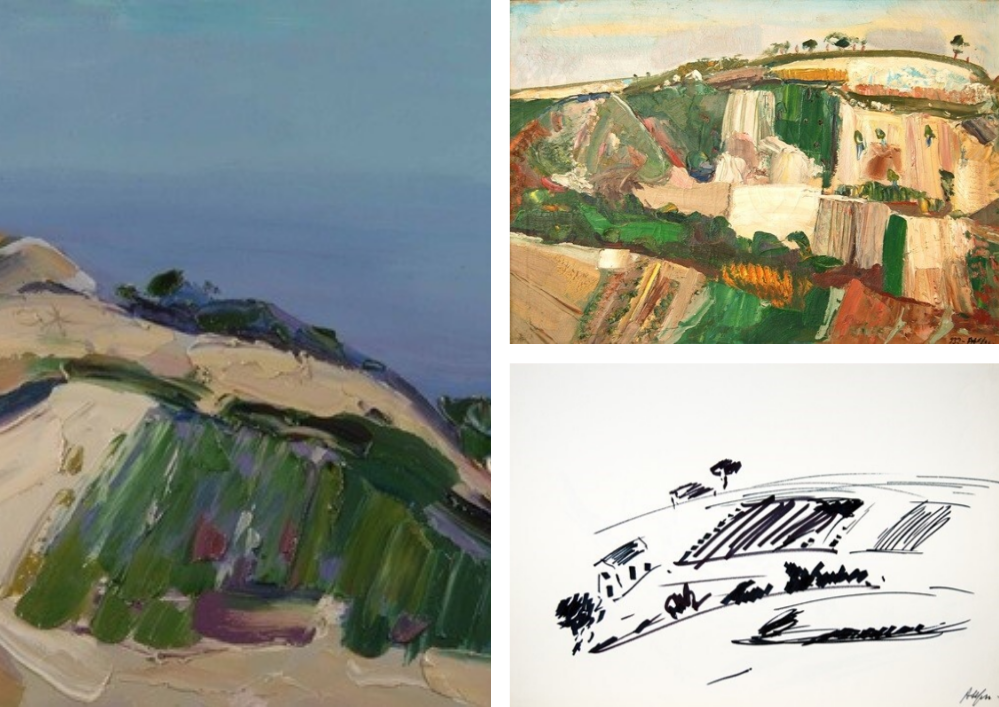La chiusura era avvenuta lo scorso 4 novembre, poiché l’ambiente doveva essere interessato «da interventi di rifunzionalizzazione degli impianti che rispecchiano la nostra volontà di offrire un Palazzo Ducale sempre più accessibile, in grado di rispondere alle moderne esigenze della museografia e di emozionare il visitatore che arriva a Urbino» aveva detto il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo.
Lo Studiolo torna a essere visibile dopo una delicata, quanto impegnativa operazione comprendente interventi di restauro e un generale riallestimento dell’ambiente al fine di restituire l’aspetto omogeneo originario dell’opera, ricucendo il rapporto tra i ritratti degli uomini famosi che l’hanno sempre caratterizzato e le pareti lignee, eliminando le superfetazioni ottocentesche, riportando quanto più possibile i colori originali della stanza, che adesso si presenta in maniera diversa perché, insieme ai 14 ritratti di uomini famosi originali, da ora in poi ospita anche le riproduzioni hi-tech degli altri 14 che attualmente si trovano al Museo del Louvre. Infatti grazie a un partenariato con il museo parigino che ha messo a disposizione le fotografie in alta risoluzione delle opere mancanti, è stato possibile ricostruire l’aspetto originale dello Studiolo del Duca, così come Federico da Montefeltro l’aveva concepito, prima degli interventi dei Barberini che ne asportarono alcune parti, alterando per sempre l’unitarietà quattrocentesca.
In soli sei mesi, quindi si è attuato il restauro e il completo riallestimento dello Studiolo così come la restituzione, più approfondita e veramente filologica, di uno dei complessi più importanti dell’architettura del Quattrocento.
A margine di tutto ciò, da sottolineare che con l’inaugurazione della grande mostra dedicata a Simone Cantarini – apertasi appena otto giorni fa come nuova tappa del cammino di riscoperta della grande arte marchigiana del Seicento – e con la riapertura dello Studiolo – con gli annessi elementi dei grandi comfort relativi all’appartamento del Duca – la Galleria Nazionale delle Marche mantiene ai massimi livelli l’offerta culturale di un’istituzione che nell’ultimo quadriennio ha visto raddoppiare i propri ingressi.
«Con il compimento dei lavori nell’appartamento del Duca – dice il Direttore Gallo – siamo al giro di boa dell’impegnativa campagna di adeguamento impiantistico, restauro e riallestimento del piano nobile del Palazzo Ducale di Urbino. Non è solo questione di quantità, quanto – e soprattutto – di qualità: con questo lotto, si riconsegnano alla fruizione gli ambienti più significativi del palazzo mentre appaiono, ricollocate nel nuovo allestimento, la maggior parte delle opere iconiche della Galleria Nazionale delle Marche: i due Piero della Francesca, la Città Ideale, Giusto di Gand, Pedro Berruguete e Paolo Uccello. L’importanza, anche scientifica, scaturita dai saggi, dalle osservazioni e dagli studi condotti a margine dei lavori, ci suggerisce anche un’iniziativa di condivisione che, molto probabilmente, nei prossimi anni ci porterà a una mostra e a una pubblicazione sul palazzo».
Cenni storico-artistici sullo Studiolo
Si tratta di un luogo di studio e di meditazione individuale le cui radici secolari affondano nei monasteri medievali. Con la riscoperta del mondo classico greco e romano da parte degli umanisti, la realizzazione di questi spazi raccolti si caricò di ulteriori significati legati alla cura dello spirito nelle ore lasciate libere dal lavoro quotidiano.
Sulla porta d’accesso dal lato della sala delle Udienze si era introdotti allo Studiolo dal ritratto dinastico di Federico e del figlio Guidubaldo del pittore spagnolo Pedro Berruguete.
L’abile scorcio dal basso e lo straordinario realismo della pittura si fondono per dare vita alla figura pubblica del signore di Urbino, rappresentato intento nella lettura, ma vestito dell’armatura che lo aveva reso grande tra i signori d’Italia. Il pittore aveva messo bene in vista i prestigiosi riconoscimenti ricevuti nell’estate del 1474 da Ferdinando d’Aragona re di Napoli, e da Edoardo IV d’Inghilterra: il collare dell’ermellino e la giarrettiera, ripetuti anche nelle tarsie.
Tradizionalmente, la conclusione della decorazione dello Studiolo è fissata al 1476, data scritta nella fascia celebrativa al di sotto del soffitto. Questo e le tarsie furono realizzati a Firenze dai fratelli Giuliano e Benedetto da Maiano, mentre i dipinti di 28 illustri personalità del mondo greco-romano e del medioevo, con significative presenze di personaggi contemporanei (l’amato maestro Vittorino da Feltre, l’amico Bessarione, papa Sisto IV), furono affidati, in Urbino, al fiammingo Giusto di Gand e poi completati dallo stesso Berruguete. La collocazione su due livelli separa gli uomini di chiesa in basso (con l’aggiunta dei poeti cristiani Dante e Petrarca), dai laici in alto. Di tutti loro Federico possedeva gli scritti nella sua biblioteca.
Più in basso, le tarsie, raffigurano scansie sui ripiani delle quali sono sparsi – in apparente disordine – armi, libri e pergamene, strumenti musicali e matematici, persino pedine degli scacchi, le Virtù teologali (Speranza, Fede e Carità) e Federico in persona. Sotto di esse, in una fascia divisa in riquadri, ci sono le imprese araldiche personali del Duca, che traducono in un sistema di simboli le sue qualità morali. A questo manifesto della cultura del signore di Urbino si unisce un gusto raffinato per il gioco arguto, che trasforma la realtà. Il realismo di stoffe e gioielli dipinti e l’illusione della prospettiva delle tarsie producono nell’osservatore l’immersione in uno spazio dove nulla è come sembra.
Nel 1631, con la morte di Francesco Maria II della Rovere, il ducato d’Urbino tornò alla Chiesa: fu allora che il cardinale Antonio Barberini, appassionato d’arte, si fece donare i dipinti dello Studiolo dallo zio papa Urbano VIII. Le grandi tavole furono strappate dalle pareti, segate in singoli riquadri e trasferite a Roma nella sua collezione; passarono quindi in quella di famiglia, dove rimasero fino al 1812.
Nel 1861, ben 14 ritratti furono acquistati da Napoleone III per il nascente Musée Napoleon, il futuro Louvre, dove attualmente si trovano. I ritratti rimasti in Italia furono acquistati dallo Stato nel 1934 e destinati alla Galleria Nazionale delle Marche.
Adesso i 14 ritratti mancanti tornano a Urbino in forma di copia identica all’originale, contribuendo a ricreare l’aspetto primitivo dello Studiolo.
Gli interventi conservativi nei secoli
La vicenda conservativa delle tarsie riporta minime modifiche ai suoi elementi, con pochi dati certi relativi alla risistemazione dello stanzino da parte del cardinal legato Pasquale Badia, di un intervento del novembre 1883, del successivo smontaggio da parte di Pasquale Rotondi, nel 1939, durante la messa in sicurezza dei beni storico-artistici dai danni della guerra, e del restauro del periodo 1969-72 eseguito a Bologna da Otello Caprara, l’ultimo in ordine di tempo prima dell’attuale. A oggi non sono note informazioni, memorie grafiche o documentarie sullo Studiolo che testimonino il suo stato nell’arco di tempo che va dal 1632 al 1852-53.
In relazione al soffitto si sa ancor meno: al di là di qualche ravvivamento della cromia degli intagli, tuttora molto visibile sull’intera superficie, l’unico restauro a oggi documentato è quello eseguito nel 1969-72 da Silvestro Castellani, il quale annotava che in precedenza esso non era mai stato oggetto di uno smontaggio.
L’attuale restauro
Nell’ambito dei lavori relativi al restauro complessivo di Palazzo Ducale di Urbino, una parte delle operazioni ha riguardato in particolare il piano nobile, dove numerosi erano stati gli interventi nel corso dell’Ottocento del Novecento.
A conferma del fatto che ogni restauro è prima di tutto un’opportunità di conoscenza, gli attuali interventi, fondati sulla ricerca storica attraverso anche l’analisi di documentazione d’archivio, hanno inteso riportare quanto più possibile gli spazi al loro aspetto originario. In tal senso il processo di restauro, curato dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo, in stretta collaborazione con il funzionario architetto Francesco Primari, lo storico dell’arte Giovanni Russo e la restauratrice Giulia Papini, ha prodotto un importantissimo accrescimento della conoscenza degli interventi subiti dal palazzo, indispensabile per la migliore tutela e valorizzazione del bene.
Più specificamente, l’intervento all’appartamento del Duca – sicuramente la parte più preziosa del palazzo -, ha riguardato lo Studiolo. Al fine di procedere all’ammodernamento degli impianti, per la prima volta lo storico ambiente è stato sottoposto a un intervento complessivo che si può così riassumere:
– smontaggio e rimontaggio di tarsie e porte, eseguito partendo dagli appunti di Pasquale Rotondi che smontò lo Studiolo per metterlo al sicuro durante la Seconda Guerra Mondiale;
– smontaggio e poi rimontaggio del soffitto ligneo, che in realtà è un controsoffitto decorato, che copre il vero soffitto costituito da un semplice tavolato;
– tutti i materiali lignei (soffitto, tarsie, Ritratti degli Uomini Illustri e porte dell’appartamento) sono stati sottoposti ad anossia, trattamento antiparassitario e poi restauro;
– realizzazione dei nuovi impianti (per questa operazione, nelle restanti sale, è stato necessario smontare porzioni di pavimento che poi sono state riposizionate);
– pulitura del pavimento in cotto (sembra che in origine, nel solo Studiolo, anche il pavimento fosse in legno) e degli elementi lapidei dell’intero appartamento;
– costruzione della nuova pannellatura nella parte alta, per ospitare riposizionare i Ritratti degli Uomini Illustri;
– posizionamento del nuovo sistema d’illuminazione nel vano della finestra dello Studiolo (effetto luce naturale) e del nuovo sistema di illuminazione (a soffitto) nelle altre sale;
– riposizionamento delle varie opere e degli arredi.
Come si può comprendere, si è trattato di un intervento sia di restauro, sia di riallestimento storico-critico dell’ambiente, estremamente complesso, che cambia completamente lo Studiolo non solo nella percezione, ma anche nella storia degli allestimenti e nella storia stessa di quell’ambiente.
Nuovo allestimento con due sorprese
Il nuovo allestimento dello Studiolo del Duca, uno dei luoghi di maggior suggestione del percorso museale della Galleria Nazionale delle Marche, ha fatto tesoro dei lunghi studi relativi alla sua primitiva realizzazione e alle vicende che ne hanno caratterizzato i quasi 550 anni di esistenza all’interno di una residenza sontuosa, fino all’attuale volontà di riportarne la lettura la più simile all’originale, anche se diversi elementi non sono più disponibili.
Infatti nello Studiolo si fondevano tarsie, pitture e intaglio ligneo, realizzati sia a Firenze, sia a Urbino, nella prima metà degli anni settanta del XV secolo. Quindi, la proposta di riallestimento ha dovuto tener conto della perdita parziale delle pitture causata dall’asportazione barberiniana del 1632 e delle modifiche che la stanza ha subito, specialmente nella parte superiore, dal 1632 alla fine degli anni settanta del secolo scorso.
In pratica si è immaginato uno spazio complesso che tenesse maggiormente conto delle strutture similari impiegate per la costruzione di polittici e di macchine d’altare ‘all’antica’, correnti nell’Italia del terzo quarto del Quattrocento. In quest’ottica si deve leggere anche la nuova proposta illuminotecnica, che ha l’obiettivo di restituire alla stanza un’atmosfera d’ambiente per valorizzarne tutte le componenti, con l’aggiunta di alcuni puntamenti localizzati.
Ma non basta.
Le ricerche condotte da Giovanni Russo, nel corso del restauro dello Studiolo, hanno permesso di restituire all’appartamento del Duca quelli che erano considerati all’epoca due grandi comfort: la latrina del Duca (spazio dedicato ai bisogni corporei che è stata riportata a una lettura completa) così come, nella camera da letto, è stato rimontato un fastosissimo lavabo che era stato smurato nel corso dell’Ottocento quando il palazzo divenne sede della Prefettura che poi, nel corso del Novecento, era stato rimontato in maniera non coerente: lo stesso Pasquale Rotondi non aveva compreso che certi elementi erratici in realtà erano parte di una sola grande struttura che è stata riconosciuta tramite documenti archivistici e, in particolare, alle accurate vedute di Romolo Liverani.
È stato quindi possibile ricomporre, nella posizione originaria nella camera da letto del Duca, questo fastoso elemento dell’arredo primitivo che contribuisce a restituire, insieme allo Studiolo, l’aspetto che aveva quella parte essenziale dell’appartamento all’interno del Palazzo Ducale.
INFO
Galleria Nazionale delle Marche
Palazzo Ducale di Urbino
Piazza Rinascimento 13, 61029 Urbino (PU)
Telefono: 0722 2760
Orari: da MA a DO: dalle 8:30 alle 19:15 (chiusura biglietteria ore 18:15); LU chiuso
Ingresso: € 12 intero; € 2 ridotto
gan-mar@cultura.gov.it
www.GNDM.it